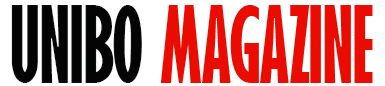Le nuove sorprese di Euclid, tra ragnatela cosmica, lenti gravitazionali e intelligenza artificiale

Alcune delle lenti gravitazionali osservate da Euclid (Immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Walmsley, M. Huertas-Company, J.-C. Cuillandre)
Centinaia di migliaia di galassie di diverse forme e dimensioni: il nuovo set di dati catturato dalla missione Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea ci regala uno scorcio della loro distribuzione su larga scala nella struttura della ragnatela cosmica.
Le nuove osservazioni del telescopio spaziale includono anche numerosi ammassi di galassie, nuclei galattici attivi e fenomeni transitori, nonché la prima classificazione di oltre 380.000 galassie e 500 possibili lenti gravitazionali.
In una sola settimana di osservazioni su tre regioni del cielo, Euclid ha individuato 26 milioni di galassie, distanti fino a 10,5 miliardi di anni luce. Nei prossimi anni queste tre regioni saranno osservate nuovamente per decine di volte, in modo da ottenere un quadro davvero “profondo” entro la fine della missione prevista per il 2030.
Con il suo strumento di imaging ad alta risoluzione (VIS), Euclid permette di rivelare la grande varietà di forme e la distribuzione di miliardi di galassie in modo molto preciso, mentre il suo strumento nel vicino infrarosso (NISP) è essenziale per svelare la distanza e la massa delle galassie.
Le nuove immagini confermano queste capacità e permettono di scorgere l’organizzazione su larga scala delle galassie nella cosiddetta ragnatela cosmica: i filamenti di materia ordinaria e materia oscura che si intrecciano nel cosmo e su cui le galassie si sono formate ed evolute. Questo aspetto, in particolare, è un elemento essenziale per la comprensione della materia oscura e dell’energia oscura, che insieme sembrano costituire il 95% dell’Universo.
Nel corso della sua missione, Euclid dovrebbe catturare le immagini di oltre 1,5 miliardi di galassie, inviando circa 100 GB di dati ogni giorno: un set di dati imponente che crea incredibili opportunità di scoperta, ma anche enormi sfide quando si tratta di cercare, analizzare e catalogare le galassie. Su questo aspetto, sta giocando un ruolo molto importante il progresso degli algoritmi di intelligenza artificiale, in combinazione con migliaia di volontari ed esperti scientifici.
Un primo importante risultato in questo senso arriva grazie al lavoro congiunto di 9976 volontari e dell'algoritmo di intelligenza artificiale Zoobot. I volontari hanno collaborato alla classificazione delle immagini di Euclid, addestrando Zoobot a riconoscere le caratteristiche delle diverse galassie. In questo modo è nato un catalogo dettagliato di oltre 380.000 galassie, classificate in base a caratteristiche come bracci a spirale, barre centrali e presenza di "code" che identificano galassie in collisione tra loro.
Questo primo catalogo, pubblicato oggi, rappresenta solo lo 0,4% del numero totale di galassie con una risoluzione simile che verranno fotografate durante la missione di Euclid. Il catalogo finale presenterà la morfologia dettagliata di un numero di galassie di almeno un ordine di grandezza più grande. Una mole di informazioni che aiuterà gli scienziati a fare luce su quesiti ancora irrisolti come la formazione dei bracci a spirale delle galassie o la crescita dei buchi neri supermassicci.
Sempre grazie alla collaborazione tra modelli di intelligenza artificiale, volontari ed esperti, oggi viene pubblicato anche un primo catalogo di 500 possibili lenti gravitazionali forti, quasi tutte finora sconosciute. Questo tipo di lente si verifica quando una galassia in primo piano e il suo alone di materia oscura agiscono come lenti, distorcendo l’immagine di una galassia sullo sfondo lungo la linea di osservazione di Euclid.
Il percorso della luce che proviene dalla galassia lontana viene distorto dalla materia normale e oscura che si trova sul suo cammino. Quando le distorsioni sono molto evidenti, il fenomeno è noto come “lente forte”.
Si prevede che entro la fine del 2026 Euclid catturerà circa 7000 possibili lenti gravitazionali, mentre saranno circa 100.000 le lenti gravitazionali forti rilevate entro la fine della missione, circa 100 volte il numero attualmente noto.
Euclid sarà anche in grado di misurare lenti gravitazionali "deboli", che si osservano quando le distorsioni delle sorgenti sono molto più piccole. Queste sottili distorsioni possono essere rilevate solo analizzando un gran numero di galassie in modo statistico. Nei prossimi anni, Euclid misurerà le forme distorte di miliardi di galassie attraverso 10 miliardi di anni di storia cosmica, fornendo così una visione 3D della distribuzione della materia oscura nel nostro Universo.
Costruito e gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Euclid nasce con il contributo della NASA e la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di numerose università italiane. Tra queste, l'Università di Bologna, con il suo Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" (DIFA), è stata tra gli ideatori e i fondatori della missione che ha poi portato allo sviluppo di Euclid. Un percorso iniziato nel 2007 con il progetto SPACE (Spectroscopic All-sky Cosmic Explorer), presentato da un team internazionale guidato dal professor Cimatti nell’ambito del programma spaziale Cosmic Vision 2015-2025 dell’ESA.