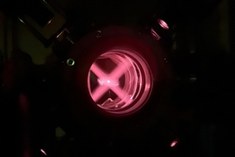Infibulazione, quando la tradizione è violenza
Mutilazione sessuale femminile. E' questo il termine medico che nasconde una pratica religiosa che nella nostra regione coinvolge quasi 1600 donne. Difficile avere una stima precisa del fenomeno che rimane in gran parte sommerso nei ghetti dove viene praticata.
(A cura della Scuola Superiore di Giornalismo)
 Una visita ginecologica di routine in una struttura ospedaliera di Bologna. La paziente si accomoda sul lettino e al medico basta uno sguardo per capire che c’è qualcosa che non va.
Una visita ginecologica di routine in una struttura ospedaliera di Bologna. La paziente si accomoda sul lettino e al medico basta uno sguardo per capire che c’è qualcosa che non va."Da quanto tempo è così signora?".
"Da sempre. E come dovrei essere?".
La giovane signora somala ha subito quella che i medici chiamano "mutilazione sessuale femminile" quando aveva solo pochi mesi. Un marchio indelebile del quale lei stessa non è consapevole.
In Emilia-Romagna, secondo una recente ricerca curata da 176 ginecologi e 241 ostetriche che operano nelle strutture pubbliche della regione, le donne infibulate dovrebbero essere dalle 900 alle 1600. Dovrebbero. "E’ impossibile fornire una stima precisa del fenomeno – spiega Anna Cometti, volontaria di origine eritrea della Cgil, con un cognome che tradisce un bisnonno giunto nel Corno d’Africa a seguito delle truppe dell’impero italiano - Mancano le occasioni di incontro tra donne immigrate e così il fenomeno resta per lo più sommerso". Anna non è favorevole alle Comunità etniche perché "monopolizzate dagli uomini, i peggiori nemici dell’integrazione femminile".
Comunità che spesso diventano veri e propri ghetti. E’ il caso del gruppo eritreo, il 90% del quale abita le cantine di via Barbieri. Tre metri per due a 200 euro al mese con contratto "uso foresteria" ed un bagno solo per corridoio. "In ambienti del genere – prosegue Anna – è verosimile che vengano perpetuate pratiche terribili come l’infibulazione". Dubbi che trovano una parziale conferma nei dati. Se l’87% degli operatori del settore afferma che la mutilazione è stata praticata nei Paesi d’origine – tra i quali Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan, Sierra Leone ed Egitto – un preoccupante 6,3% ritiene che l’operazione sia stata eseguita in Italia, da personale specializzato o da mammane tradizionali.
Una realtà che prende in contropiede i medici per primi. Deinfibulare o seguire una gestante mutilata non sono operazioni che rientrano nella letteratura medica nostrana. "Non esistono ancora trattati sulla materia – confermano il dottor Giorgio Scagliarini e l’ostetrica Morena Fogli della clinica villa Erbosa – tutto quello che facciamo è frutto di studi personali, esperienza sul campo e volontariato. E, per di più, non esiste un monitoraggio sulle utenti. Spesso le donne vanno a partorire nei Paesi d’origine".
In Italia, fino a poco tempo fa, assistere una partoriente infibulata equivaleva praticare il taglio cesareo: il tasso di questo tipo di intervento su donne sottoposte ad infibulazione "faraonica" – che prevede non solo la clitoridectomia ma anche la cucitura quasi totale delle grandi labbra – è, in percentuale, molto più alto rispetto a quello dei Paesi interessati, dove i medici hanno le competenze per affrontare, in questi casi, parti naturali.
Le cose però stanno cambiando. La fiducia nelle strutture sanitarie aumenta grazie al passaparola tra amiche e comincia ad abbattere i muri delle comunità. Negli ultimi due anni, alla Ausl di villa Erbosa, si sono rivolte una ventina di donne mutilate. Alcune per essere assistite nel parto. "Ora – spiega il dottor Corrado Melega, direttore dell’unità operativa della clinica – cerchiamo di agire prima della nascita del bambino, rimovendo la "cucitura" il prima possibile".
Altre, ragazze spesso poco più che adolescenti, chiedono di essere deinfibulate. "Si stanno integrando – racconta l’ostetrica – e non sentono più l’esigenza di portare con loro questo segno".
All’approccio medico occorre però associare un appoggio psicologico. "Quando avviciniamo una paziente – spiega Morena – prima di tutto cerchiamo il dialogo. Non da dottore a paziente ma da donna a donna, senza la mediazione di cartelle cliniche asettiche. E’ un po’ come prendere un tè insieme". "Cerchiamo di abbattere i limiti culturali e linguistici – prosegue il dottor Melega – già a partire dai termini. E così traduciamo mutilazione genitale femminile con cucitura, per esempio". "Sono necessari progetti e campagne reali e non solo di facciata – rincara la dose Anna Cometti – mirati alle donne e alla loro integrazione".
Una sensibilità condivisa dall’Amministrazione regionale che ha messo in cantiere un progetto dedicato alla formazione di operatori in ogni Usl del territorio. E non solo. "Oltre alla formazione per gli operatori del settore – spiega Gianluca Borghi, assessore regionale alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani e Cooperazione internazionale – la regione Emilia-Romagna sta portando avanti iniziative di cooperazione direttamente nei Paesi interessati dal fenomeno. Abbiamo, per esempio, dei progetti in Eritrea in collaborazione con alcune Organizzazioni non governative volti alla sensibilizzazione della popolazione in loco". Progetti e iniziative di prevenzione, aiuto, ma anche di monitoraggio, che non hanno nulla a che vedere con la discussa proposta di "infibulazione soft" avanzata dal medico somalo dell’ospedale Careggi di Firenze Omar Abdulkadir. "Ne capiamo le motivazioni – dice il dottor Scagliarini – ma non condividiamo questo tipo di approccio al problema. Così facendo si legittima una pratica lesiva dell’integrità psichica e fisica di ragazze e bambine, anche di pochi mesi". Un compromesso però che secondo Borghi almeno "limiterebbe il danno".
Dietro alla pratica della "circoncisione femminile" si nascondono giustificazioni religiose e sociali. Recidere la parte "maschile" della ragazza, la clitoride, residuo della bisessualità divina. Assicurarsi la fedeltà della donna con una cintura di castità cucitale addosso presso popolazioni pastorali in cui gli uomini dovevano assentarsi per lunghi periodi. "Sancire l’inferiorità della donna nei confronti dell’uomo con una violenza fisica e psicologica – si arrabbia Maria –. E per favore smettiamola di credere e dire che si tratta di una questione culturale".